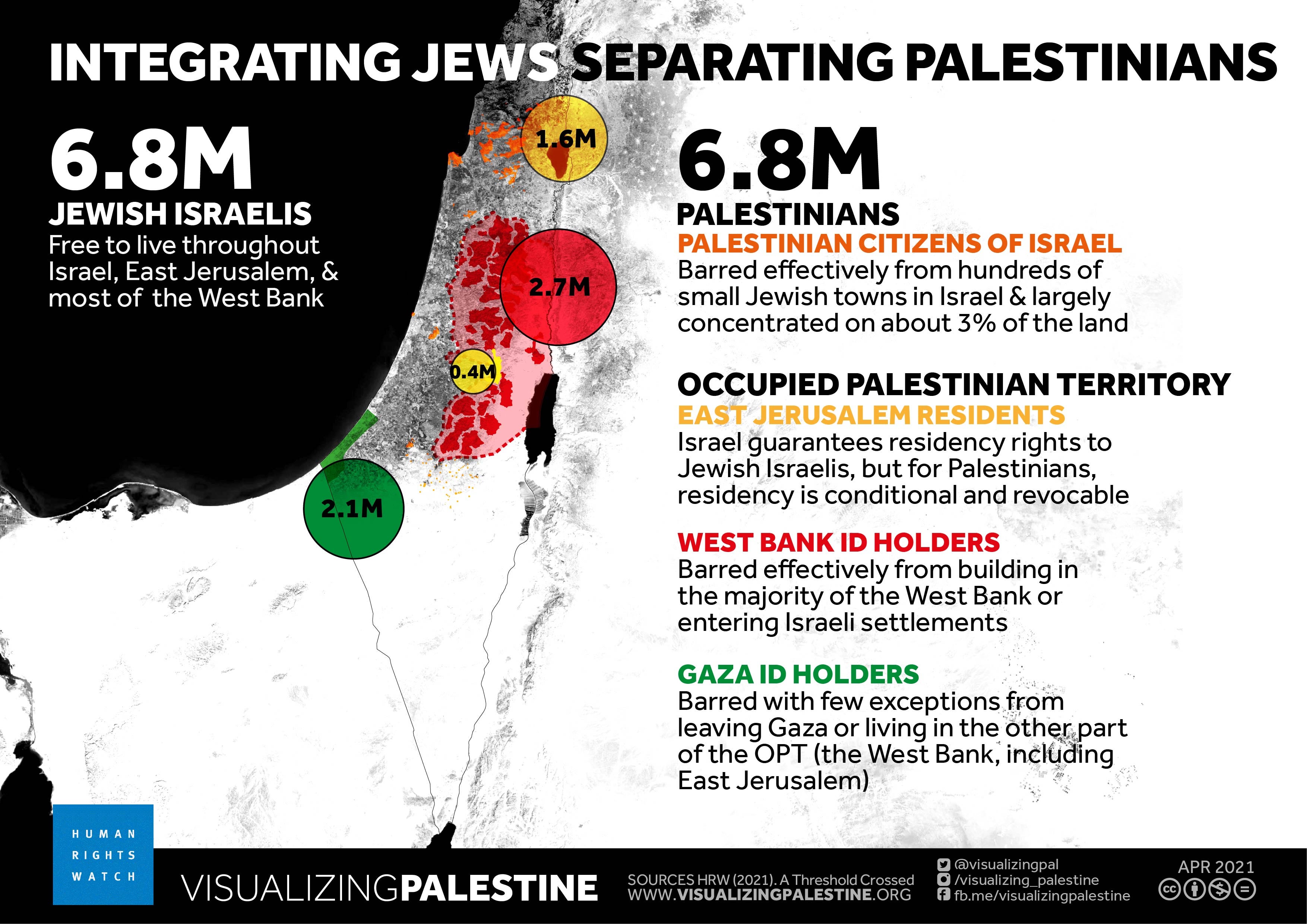All’età di 90 anni ci ha lasciati Desmond Tutu, arcivescovo anglicano di Città del Capo, premio Nobel per la Pace grazie al suo impegno per la Conciliazione in Sud Africa.
Simbolo della lotta contro l’apartheid. Insieme a Nelson
Mandela sosteneva che il popolo sudafricano non sarebbe stato completamente
libero senza la libertà del popolo palestinese.
Di qui
l’appello al popolo al popolo
d’Israele affinché si liberi liberando la Palestina.
AL POPOLO D’ISRAELE: LIBERATE VOI STESSI
LIBERANDO LA PALESTINA
24 agosto 2014
Nelle ultime settimane, membri della
società civile del mondo intero hanno lanciato azioni senza precedenti contro
le risposte brutali e sproporzionate di Israele al lancio di razzi dalla
Palestina. Se sommiamo tutti i partecipanti alle manifestazioni dell’ultimo
weekend per chiedere giustizia in Israele e Palestina – a Cape Town,
Washington, New York, Nuova Delhi, Londra, Dublino, Sydney, e in tutte le altre
città – troviamo senza alcun dubbio la rappresentazione della più importante
mobilitazione dell’opinione pubblica per un’unica causa mai vista nella storia
dell’umanità. Un quarto di secolo fa, ho preso parte a manifestazioni
contro l’apartheid, che avevano raccolto moltissime persone.
Non avrei mai immaginato che avremmo
nuovamente assistito a manifestazioni di tale portata, ma quella di sabato
scorso a Cape Town è stata almeno della stessa importanza. Tra i manifestanti
c’erano giovani ed anziani, musulmani, cristiani, ebrei, indù, buddisti,
agnostici, atei, neri, bianchi, rossi e verdi… E’ quanto ci si può aspettare da
una nazione vivace, tollerante e multiculturale.
Ho chiesto alla folla di cantare con me:
“Siamo contro l’ingiustizia dell’occupazione illegale della Palestina. Siamo
contro le uccisioni a Gaza. Siamo contro le umiliazioni inflitte ai palestinesi
ai posti controllo e di blocco delle strade. Siamo contro le violenze
perpetrate da tutte le parti in causa. Ma non siamo contro gli ebrei.”
Precedentemente, nella settimana, avevo
fatto un appello per la sospensione della partecipazione di Israele all’Unione
Internazionale degli Architetti, che si teneva in Sudafrica. Ho invitato le
sorelle ed i fratelli israeliani presenti alla conferenza a dissociarsi
attivamente, nell’ambito della loro professione, dalla progettazione e dalla
costruzione di infrastrutture finalizzate a perpetuare l’ingiustizia, in
particolare tramite il muro di separazione, i terminali di sicurezza, i posti
di controllo e la costruzione di colonie edificate sui territori palestinesi
occupati.
Ho detto loro: “Vi prego di portare con
voi questo messaggio: per favore, invertite il corso della violenza e
dell’odio, unendovi al movimento non violento per la giustizia per tutti gli
abitanti della regione”. Nelle ultime settimane, più di 1,7 milioni di persone
in tutto il mondo hanno aderito al movimento unendosi ad una campagna di Avaaz
che chiede alle compagnie che traggono profitto dall’occupazione israeliana e/o
sono coinvolte nei maltrattamenti e nella repressione dei palestinesi, di
ritirarsi. La campagna è rivolta specificamente ai fondi di pensione dei Paesi
Bassi, ABP, alla Barclays Bank, al fornitore di sistemi di sicurezza G4S, alle
attività di trasporto dell’azienda francese Véolia, all’azienda di computer
Hewlett-Packard, e al costruttore di bulldozer Caterpillar.
Il mese scorso 17 governi europei hanno
invitato i propri cittadini ad interrompere le relazioni commerciali e gli
investimenti nelle colonie israeliane illegali. Recentemente, si è potuto vedere il fondo
pensionistico olandese PGGM ritirare decine di milioni di euro dalle banche
israeliane, la fondazione Bill e Melinda Gates disinvestire da G4S, e la chiesa
presbiteriana americana annullare un investimento di circa 21 milioni di
dollari nelle imprese HP, Motorola Solutions e Caterpillar. E’ un movimento che
si va ampliando. La violenza genera violenza e odio, che a sua volta non
fanno che produrre altra violenza e odio. Noi sudafricani conosciamo
bene la violenza e l’odio. Sappiamo cosa significa essere dimenticati dal
mondo, quando nessuno vuole capire o anche solo ascoltare ciò che noi
esprimiamo. Questo fa parte delle nostre radici e del nostro vissuto. Ma
sappiamo anche ciò che il dialogo tra i nostri dirigenti ha permesso, quando
delle organizzazioni accusate di “terrorismo” vennero nuovamente autorizzate ad
esistere, ed i loro capi, tra cui Nelson Mandela, vennero liberati dalla
prigione o dall’esilio.
Noi sappiamo che quando i nostri
dirigenti hanno cominciato a parlarsi, la logica della violenza che aveva
frantumato la nostra società si è dissolta, fino a scomparire. Gli atti terroristici che avvennero dopo l’inizio di
questi cambiamenti – come gli attacchi ad una chiesa e ad un bar – furono
unanimemente condannati, e chi ne era stato l’artefice non trovò più alcun
consenso quando la parola passò alle urne. L’euforia che seguì a questa prima
votazione non si limitò ai soli sudafricani neri. La nostra soluzione
pacifica era meravigliosa perché ci includeva tutti quanti. E quando, in
seguito, abbiamo dato vita ad una costituzione così tollerante, generosa ed
aperta, che dio stesso ne sarebbe andato fiero, ci siamo sentiti tutti come
liberati.
Certo, il fatto di aver avuto dei
dirigenti straordinari ci ha aiutato. Però, ciò che alla fine ha spinto questi
dirigenti a riunirsi intorno ad un tavolo di negoziati è stato l’insieme di
strumenti efficaci e nonviolenti che erano stati messi in atto per isolare il
Sudafrica sul piano economico, accademico, culturale e psicologico. In un
momento chiave, il governo dell’epoca aveva finito per rendersi conto che
continuare con l’apartheid avrebbe costituito più un danno che un vantaggio. L’embargo
sul commercio applicato negli anni ’80 al Sudafrica da alcune multinazionali
impegnate fu un fattore determinante per la caduta, senza spargimento di
sangue, del regime di apartheid. Queste imprese avevano capito che
sostenendo l’economia sudafricana contribuivano al mantenimento d’uno statu quo
ingiusto.
Coloro che continuano a fare affari con
Israele, contribuendo così a garantire un senso di “normalità” alla società
israeliana, rendono un pessimo servizio ai popoli di Israele e Palestina.
Contribuiscono al mantenimento d’uno statu quo profondamente ingiusto. Chi
sostiene l’isolamento temporaneo di Israele afferma che israeliani e
palestinesi hanno gli stessi diritti alla dignità e alla pace. In ultima
analisi, gli eventi che hanno avuto luogo a Gaza nell’ultimo mese sono un test
per chi crede nei valori umani. E ‘sempre più evidente che i politici e i
diplomatici sono incapaci di trovare risposte, e che la responsabilità di
negoziare una soluzione duratura alla crisi in terra santa è in capo alla
società civile ed ai popoli stessi di Israele e della Palestina. Al di là della
recente devastazione di Gaza, persone oneste provenienti dal mondo intero – in
particolare in Israele – sono profondamente turbate dalle violazioni quotidiane
della dignità umana e della libertà di movimento, che i palestinesi subiscono
ai posti di controllo e ai blocchi stradali. Inoltre, le politiche israeliane
di occupazione illegale e la costruzione di edifici in zone tampone sul
territorio occupato aumentano la difficoltà di raggiungere un accordo che sia
accettabile da tutti per il futuro.
Lo stato di Israele agisce come se non
esistesse un domani. I suoi abitanti con
conosceranno l’esistenza tranquilla e sicura a cui aspirano, ed a cui hanno
diritto, finché i loro dirigenti perpetueranno le condizioni che determinano il
perdurare del conflitto. Ho condannato coloro che in Palestina sono
responsabili dei lanci di missili e razzi su Israele. Essi attizzano il fuoco
dell’odio. Io sono contro ogni forma di violenza. Ma occorre essere chiari, il
popolo di Palestina ha tutto il diritto di lottare per la propria dignità e
libertà. Questa lotta è sostenuta da molte persone in tutto il mondo. Nessun
problema creato dall’uomo è senza via d’uscita, se gli uomini mettono in comune
i loro sinceri sforzi per risolverlo. Nessuna pace è impossibile se le
persone sono determinate ad ottenerla. La pace necessita che il popolo
israeliano e quello palestinese riconoscano l’essere umano che è in loro e si
riconoscano reciprocamente per comprendere la propria interdipendenza. I
missili, le bombe e le invettive brutali non sono la soluzione.
Non esiste soluzione militare. La soluzione verrà più probabilmente dai mezzi
nonviolenti che abbiamo sviluppato in Sudafrica negli anni ’80 per persuadere
il governo sudafricano della necessità di cambiare la sua politica. La
ragione per cui questi strumenti – boicottaggio, sanzioni e disinvestimenti –
si sono alla fine rivelati efficaci, è che avevano il sostegno di una massa
critica, sia all’interno del paese che all’estero. Lo stesso tipo di
sostegno nei confronti della Palestina di cui siamo stati testimoni nel mondo
durante queste ultime settimane. La mia preghiera al popolo di Israele è di
guardare al di là del momento contingente, di guardare al di là della rabbia
per essere costantemente sotto assedio, di concepire un mondo in cui Israele e
la Palestina coesistono – un mondo in cui regnano la dignità ed il rispetto
reciproco. Ciò richiede un cambiamento di paradigma.
Un cambiamento che riconosca che un
tentativo di mantenere lo statu quo è destinato a condannare le prossime
generazioni alla violenza e all’insicurezza. Un cambiamento che smetta di
considerare una critica legittima alla politica dello stato come un attacco
contro gli ebrei. Un cambiamento che ha inizio all’interno e si propaga,
attraverso le comunità, le nazioni e le regioni, alla diaspora che è diffusa in
tutto il mondo di cui facciamo parte. Il solo mondo di cui facciamo parte! Quando
i popoli si uniscono per una causa giusta, sono invincibili. Dio non
interferisce nelle vicende umane, nella speranza che la risoluzione dei nostri
conflitti ci farà crescere ed imparare da soli. Però dio non dorme. I testi
sacri ebraici dicono che dio sta dalla parte dei deboli, dei poveri, delle
vedove, degli orfani, dello straniero che ha permesso a degli schiavi di
compiere il loro esodo verso una Terra Promessa. E’ stato il profeta Amos a dire che dovremmo
lasciare che la giustizia scorra come un fiume. Alla fine, il bene trionferà.
Cercare di liberare il popolo di Palestina dalle umiliazioni e dalle persecuzioni che gli vengono inflitte dalla politica di Israele è una causa nobile e giusta. E’ una causa che il popolo di Israele ha l’obbligo per sé stesso di sostenere.
Nelson Mandela ha detto che i sudafricani non si
sentiranno completamente liberi finché i palestinesi non lo saranno. Avrebbe
potuto aggiungere che la liberazione della Palestina sarebbe anche la
liberazione di Israele.
Testo originale in Desmond Tutu: la mia
preghiera al popolo di Israele: liberatevi liberando la Palestina -
Invictapalestina